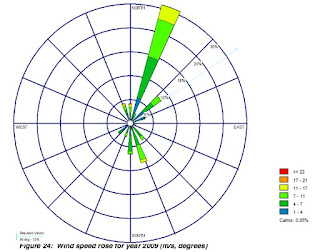Nell'agosto del 2016 uno studio epidemiologico, commissionato dalla Regione Puglia, ha stabilito, senza ombra di dubbio, che gli inquinanti emessi dalle attività a caldo dell'acciaieria di Taranto, sono responsabili di:
- significativi aumenti (+ 24%) di ricoveri per malattie respiratorie dei bambini che abitano nei quartieri Tamburi e Paolo VI
- aumento della mortalità, per tumore polmonare e infarti di chi abita sottovento agli impianti
L'indagine ha anche escluso che queste differenze siano attribuibili a fattori socioeconomici a fumo e alcool.
La responsabilità di questi danni alla salute è stata confermata dal fatto che l'andamento della mortalità corrisponde ad un simile andamento dell'inquinamento e della produzione di acciaio:
più acciaio prodotto, livelli di inquinamento più alti, maggior numero di morti nella popolazione esposta.
E' certo che la fonte prevalente dell'inquinamento, in particolare di elevate emissioni di potenti cancerogeni quali idrocarburi policiclici aromatici e diossine, siano i reparti che, a partire dl carbone, producono carbon coke.
Il carbon coke, mescolato all'ossido di ferro, trasforma questo minerale in ferro metallico ( ghisa) , con un processo chimico denominato riduzione.
Anche se il carbone è ancora la principale materia prima per produrre ghisa e successivamente acciaio, la riduzione dell'ossido di ferro si può ottenere anche senza carbone.
Per trasformare l'ossido di ferro in ghisa si può usare anche l'ossido di carbonio (CO) e l'idrogeno che si ottiene per "reforming" del metano.
Questa tecnologia, denominata Midrex, è utilizzata da anni negli Stati Uniti e sostituisce i reparti più inquinanti della produzione dell'acciaio che fa uso di carbone: il deposito carbone, le cokerie, l'agglomerazione, gli altiforni.
I vantaggi ambientali della conversione al metano al posto del carbone, sono stati valutati dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile.
A fronte di una produzione annua di 8 milioni di tonnellate di acciaio con il processo Midrex si ha una minore produzione di anidride carbonica (-63%) , di anidride solforosa ( - 68%), di ossidi di azoto ( -46%), l'azzeramento delle ricadute di polvere di carbone e l'azzeramento delle emissioni di particolato, di diossine, di idrocarburi policiclici aromatici.
Questa tecnologia è quella che applicherebbe la Jindal South West, una società indiana che, in cordata con la Cassa Depositi e prestiti, la Delfin di Del Vecchio e Arvedi, sono interessati all'acquisto delle acciaierie di Taranto.
Tuttavia, al momento, sembrerebbe che abbia vinto il vecchio carbone, in quanto la gara è stata aggiudicata all'Arcelor Mittal, ma il Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto ricorso al TAR e il nuovo governo giallo- verde, con Di Maio al Ministero dello Sviluppo economico, potrebbe dar fiato alla "decarbonizzazione" dell'ILVA che tanto piace a Michele Emiliano che, anche su questo tema si è posto in rotta di collisione con il suo partito, il PD, uscito pesantemente penalizzato dalle ultime elezioni.
In particolare, il Contratto tra il M5S e la Lega, per quanto riguarda l'ILVA di Taranto, parla di una progressiva chiusura delle fonti inquinanti in grado di proteggere i livelli occupazionali: leggendo tra le righe si potrebbe prefigurare proprio la scelta del passaggio al metano.
Il partito del carbone, in gravi difficoltà a livello mondiale, a Taranto potrebbe essere sconfitto dal partito del metano che, grazie alla scelta di decarbonizzare, potrebbe prendere i classici 2 due piccioni con una fava": la chiusura dei reparti più inquinanti, una produzione di acciaio di qualità pari a 10-12 milioni di tonnellate/anno di acciaio e il mantenimento della occupazione.
La nuova ILVA, se si riuscirà a farla, avrà bisogno di 3,5 miliardi di metri cubi di metano all'anno.
Il presidente Emiliano pensa che, a tale scopo, potrebbe venir bene il progettato metanodotto (TAP) che, attraversato lo Ionio, dovrebbe approdare alle coste pugliesi e lasciando a Taranto il 17,5 % della portata di metano, potrebbe garantire l'operatività delle acciaierie.
All'interno dei Cinque Stelle, ci sono posizione contrarie al TAP, anche se questo tema non è esplicitato nel Contratto.
Tuttavia esiste un' altra interessante possibilità che si potrebbe agganciare al tema dell'economia verde, inserito nel Programma: un piano nazionale di efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale, finalizzato a ridurre il consumo di metano per il riscaldamento domestico che, nel 2016, ha usato 31,4 miliardi di metri cubi di metano.
Come si vede, basterebbe ridurre del 11% i consumi nazionali di metano, con una seria Grande Opera un migliore isolamento di tetti, infissi e pareti e una migliore regolazione delle temperature interne in gran parte delle abitazioni italiane, per avere a disposizione, senza TAP, tutto il gas che servirebbe all' ILVA di Taranto per produrre acciaio senza inquinamento.
E' un obiettivo assolutamente raggiungibile in quanto, se adottassimo per le nostre abitazioni gli standard di consumi energetici svedesi, la quota di gas metano che oggi usiamo per riscaldare le nostre case passerebbe dall'attuale 30% al 7%, di tutto il metano oggi usato nel nostro Paese.
E, in prospettiva, esiste anche una interessante soluzione per auto-produrre il metano da usare a Taranto.
La soluzione è quella del biometano, che farebbe contento Salvini (il bio-metano prodotto in Italia per gli italiani) ma anche Di Maio, che nel suo piano Rifiuti Zero, inserito in Contratto, non esclude che da tutti i nostri scarti biodegradabili si possa produrre biometano da immettere nella rete del gas.
La produzione di biometano avviene con tecniche di trattamento biologico delle frazioni biodegradabili dei nostri scarti agricoli, da allevamenti, da mense e cucine.
Queste tecniche sono mature e economicamente competitive, da un decennio già usate in diversi paesi (Svezia, Svizzera, Germania...) e con i primi impianti italiani già operativi.
A tal riguardo, uno studio ENEA ha valutato che la produzione nazionale di biometano potrebbe essere compresa tra 7,6 a 3,3 miliardi di metri cubi all'anno, compatibile con i consumi della acciaieria di Taranto convertita a metano.
Insomma, se si vorrà, tra qualche anno l'acciaieria di Taranto, completamente decarbonizzata, potrebbe produrre acciaio usando, come fonte di energia rinnovabile, il metano prodotto dagli scarti di cucina degli italiani, ovviamente rigorosamente raccolti in modo differenziato.
E anche questo potrebbe essere uno dei tanti cambiamenti che il nuovo governo auspica e che, se vuole, potrebbe realizzare.
Aggiornamento di settembre 2018: il ministro Di Maio ha chiuso l'accordo per le acciaierie, che restano a carbone.
E' certo che la fonte prevalente dell'inquinamento, in particolare di elevate emissioni di potenti cancerogeni quali idrocarburi policiclici aromatici e diossine, siano i reparti che, a partire dl carbone, producono carbon coke.
Il carbon coke, mescolato all'ossido di ferro, trasforma questo minerale in ferro metallico ( ghisa) , con un processo chimico denominato riduzione.
Anche se il carbone è ancora la principale materia prima per produrre ghisa e successivamente acciaio, la riduzione dell'ossido di ferro si può ottenere anche senza carbone.
Per trasformare l'ossido di ferro in ghisa si può usare anche l'ossido di carbonio (CO) e l'idrogeno che si ottiene per "reforming" del metano.
Questa tecnologia, denominata Midrex, è utilizzata da anni negli Stati Uniti e sostituisce i reparti più inquinanti della produzione dell'acciaio che fa uso di carbone: il deposito carbone, le cokerie, l'agglomerazione, gli altiforni.
I vantaggi ambientali della conversione al metano al posto del carbone, sono stati valutati dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile.
A fronte di una produzione annua di 8 milioni di tonnellate di acciaio con il processo Midrex si ha una minore produzione di anidride carbonica (-63%) , di anidride solforosa ( - 68%), di ossidi di azoto ( -46%), l'azzeramento delle ricadute di polvere di carbone e l'azzeramento delle emissioni di particolato, di diossine, di idrocarburi policiclici aromatici.
Questa tecnologia è quella che applicherebbe la Jindal South West, una società indiana che, in cordata con la Cassa Depositi e prestiti, la Delfin di Del Vecchio e Arvedi, sono interessati all'acquisto delle acciaierie di Taranto.
Tuttavia, al momento, sembrerebbe che abbia vinto il vecchio carbone, in quanto la gara è stata aggiudicata all'Arcelor Mittal, ma il Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto ricorso al TAR e il nuovo governo giallo- verde, con Di Maio al Ministero dello Sviluppo economico, potrebbe dar fiato alla "decarbonizzazione" dell'ILVA che tanto piace a Michele Emiliano che, anche su questo tema si è posto in rotta di collisione con il suo partito, il PD, uscito pesantemente penalizzato dalle ultime elezioni.
In particolare, il Contratto tra il M5S e la Lega, per quanto riguarda l'ILVA di Taranto, parla di una progressiva chiusura delle fonti inquinanti in grado di proteggere i livelli occupazionali: leggendo tra le righe si potrebbe prefigurare proprio la scelta del passaggio al metano.
Il partito del carbone, in gravi difficoltà a livello mondiale, a Taranto potrebbe essere sconfitto dal partito del metano che, grazie alla scelta di decarbonizzare, potrebbe prendere i classici 2 due piccioni con una fava": la chiusura dei reparti più inquinanti, una produzione di acciaio di qualità pari a 10-12 milioni di tonnellate/anno di acciaio e il mantenimento della occupazione.
La nuova ILVA, se si riuscirà a farla, avrà bisogno di 3,5 miliardi di metri cubi di metano all'anno.
Il presidente Emiliano pensa che, a tale scopo, potrebbe venir bene il progettato metanodotto (TAP) che, attraversato lo Ionio, dovrebbe approdare alle coste pugliesi e lasciando a Taranto il 17,5 % della portata di metano, potrebbe garantire l'operatività delle acciaierie.
All'interno dei Cinque Stelle, ci sono posizione contrarie al TAP, anche se questo tema non è esplicitato nel Contratto.
Tuttavia esiste un' altra interessante possibilità che si potrebbe agganciare al tema dell'economia verde, inserito nel Programma: un piano nazionale di efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale, finalizzato a ridurre il consumo di metano per il riscaldamento domestico che, nel 2016, ha usato 31,4 miliardi di metri cubi di metano.
Come si vede, basterebbe ridurre del 11% i consumi nazionali di metano, con una seria Grande Opera un migliore isolamento di tetti, infissi e pareti e una migliore regolazione delle temperature interne in gran parte delle abitazioni italiane, per avere a disposizione, senza TAP, tutto il gas che servirebbe all' ILVA di Taranto per produrre acciaio senza inquinamento.
E' un obiettivo assolutamente raggiungibile in quanto, se adottassimo per le nostre abitazioni gli standard di consumi energetici svedesi, la quota di gas metano che oggi usiamo per riscaldare le nostre case passerebbe dall'attuale 30% al 7%, di tutto il metano oggi usato nel nostro Paese.
E, in prospettiva, esiste anche una interessante soluzione per auto-produrre il metano da usare a Taranto.
La soluzione è quella del biometano, che farebbe contento Salvini (il bio-metano prodotto in Italia per gli italiani) ma anche Di Maio, che nel suo piano Rifiuti Zero, inserito in Contratto, non esclude che da tutti i nostri scarti biodegradabili si possa produrre biometano da immettere nella rete del gas.
La produzione di biometano avviene con tecniche di trattamento biologico delle frazioni biodegradabili dei nostri scarti agricoli, da allevamenti, da mense e cucine.
Queste tecniche sono mature e economicamente competitive, da un decennio già usate in diversi paesi (Svezia, Svizzera, Germania...) e con i primi impianti italiani già operativi.
A tal riguardo, uno studio ENEA ha valutato che la produzione nazionale di biometano potrebbe essere compresa tra 7,6 a 3,3 miliardi di metri cubi all'anno, compatibile con i consumi della acciaieria di Taranto convertita a metano.
Insomma, se si vorrà, tra qualche anno l'acciaieria di Taranto, completamente decarbonizzata, potrebbe produrre acciaio usando, come fonte di energia rinnovabile, il metano prodotto dagli scarti di cucina degli italiani, ovviamente rigorosamente raccolti in modo differenziato.
E anche questo potrebbe essere uno dei tanti cambiamenti che il nuovo governo auspica e che, se vuole, potrebbe realizzare.
Aggiornamento di settembre 2018: il ministro Di Maio ha chiuso l'accordo per le acciaierie, che restano a carbone.